| |
to, con la struttura ordinata, perfettamente equilibrata, del
concerto non descrittivo.
Lo schema di ciascun concerto è preceduto da un sonetto che descrive
le quattro stagioni; pezzo per pezzo frammenti dei poemi sono
stampati sulle parti strumentali, al di sotto dell'episodio a cui si
riferiscono, e i quadri più significativi hanno un titolo,
differenziato, talvolta, in relazione allo strumento a cui sono
associati. Per lo stesso passaggio de La primavera la parte
del violino solo porta l'indicazione: "II capraro che dorme",
quella della viola "il cane che grida".
Vivaldi non s'accontenta di elaborare una serie di composizioni
brillanti, ma conferisce loro un ordine strutturale, tipico del
concerto non descrittivo. Identica è la disposizione generale dei
movimenti: un sonno tra un temporale e una danza campestre,
una pausa di racco-glimento accanto al fuoco tra due tempeste
d'inverno altro non sono che il "largo" o "l'adagio" di mezzo,
inquadrati tra due movimenti vivaci.
I "soli" sono pezzi di virtuosistici, ma evocano anche dettagli
caratteristici, mormorii di sorgenti, canti di uccelli, l'incerto
passo dell'ubriaco, lo scivolare del viaggiatore durante l'inverno.
Questa idea di trattare una musica con un programma, facendola
nel contempo quadrare all'interno delle strut-ture formali rigorose
del concerto, era in sé stessa interessante e nuova. Ciò che ne
accentua l'originalità è la libertà, la fantasia, l'apparente
spontaneità della descrizione sia nei brani virtuosistici
del solista che nel colore dell'orchestra che l'accompagna, o che
gli rispon-de.
Intorno alla metà' del Settecento, Baldassare Galuppi (1706 -
1785), detto il Buranello dall'isola della laguna che gli dette i
natali, era indubbiamente l'operista italiano di maggior successo.
Compositore straordinariamente prolifico, la sua fama, estesa anche
nei maggiori centri europei, si fondò in un primo momento sulle
favole pastorali e sulle opere serie (Gustavo I rè di Svezia), alle
quali si aggiunsero in seguito le opere buffe (L'Arcadia in
Brenta, Il mondo della luna, Il filosofo di campagna), frutto
in primo luogo dell'intensa collaborazione intercorsa tra il Buranello e Carlo Goldoni. |
Ma ancor oggi la produzione melodrammatica galuppiana è a stento
documentabile, in ragione soprattutto della maniera in cui la sua
musica è stata tramandata, attraverso centinaia di partiture
conservate e migliaia di arie tramandate separatamente, musicate più
e più volte e senza alcun riferimento preciso all'opera dalla quale
furono estrapolate.
D'altro canto anche la produzione strumentale di Galuppi è in parte
quasi sconosciuta al pubblico e manca ancora di chiarificazioni
esegetiche.
Durante la sua variegata carriera, fu vice-maestro (1748 - 62) e
maestro di cappella ( 1762 - 85 ) a San Marco, maestro di musica
presso l'Ospedale dei Mendicanti (1740 - 1751) e maestro di coro
all'Ospedale degli Incurabili (1768 - 76); la sua fama operistica lo
portò a soggiornare a Londra (1741 - 43) e a San Pietroburgo (1766 -
68).
Fu parallelamente a queste cariche che Galuppi, nono-stante
intensificasse la sua produzione con il repertorio sacro e quello
melodrammatico, si occupò anche di musica strumentale, scrivendo
concerti, sinfonie, ouvertures, e una cospicua serie di sonate per
strumento a tastiera.
Queste composizioni, pur essendo di buona fattura e in sintonia con
quelli che erano i dettami modaioli imposti dai rinnovamenti
stilistici introdotti maggiormente oltre i territori lagunari, non
presentano novità di rilievo e non possiedono l'importanza e il peso
storico dei numero-si melodrammi creati dallo stesso Buranello.
Ma accanto a musiche forgiate secondo criteri stilistici precisi,
Venezia nel '700 ha visto il dilagare di una letteratura musicale di
piccolo respiro, nota nel genere della "canzone da battello".
denominazione prettamente di marca lagunare, indicante un repertorio
vastissimo, ancor oggi sconosciuto ed inedito.
Memori della Barca di Venetia per Padova (1605) di Adriano
Banchieri, le canzoni da battello (il cui corpus maggiore è
costituito dagli oltre duecento manoscritti conservati nella
raccolta del Museo Correr, attual-mente collocata presso la
Biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello) con i loro testi
dialettali suggestivi, ricchi di musicalità, di espressioni
linguistiche raffinate e sottili, intessuti di pennellate e di squarci di vita quoti- |
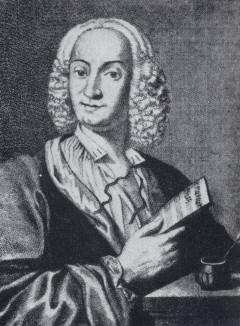
Antonio Vivaldi
Venezia 1678 - Vienna 1741
Il Sonetto intitolato
alla Primavera:
"Giunt'è la Primavera e
festosetti
La salutari gli Augei con lieto canto
E i fonti allo spirar de' Zeffiretti
Con dolce mormorio scorrono intanto.
Vengon coprendo l'aer di nero
amanto
E lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti;
Indi. tacendo questi, gli Augelletti
Tornan di nuovo al lor canoro incanto.
E quindi sul fiorito ameno prato
Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme'l Caprar col fido can a lato.
Di pastoral zampogna al suon
festante
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato
Di primavera all'apparir brillante."
|